Storico
Ascoli Satriano 26 giugno 1881 - Milano 5 luglio 1938
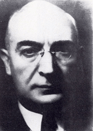
Nell’ambito della Scuola storiografica economico-giuridica, che tanta importanza ha avuto per la cultura italiana tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, un ruolo non secondario svolse Romolo Caggese
La vita e gli studi
Nacque in provincia di Foggia, ad Ascoli Satriano, il 26 giugno del 1881, in una famiglia della media borghesia, da Potito e da Amalia Ursomando; rimase in paese sino all'età di sedici anni, alunno del Seminario locale, poi si trasferì a Foggia, per frequentarvi il Liceo sotto la guida dell'illustre storico pugliese Francesco Carabellese, e, nel 1898, fu testimone dell'assalto al Municipio da parte del popolo infuriato per la fame e le tasse, come ebbe a ricordare, anni dopo, in Foggia e la Capitanata.
Da allora ritornò solo saltuariamente nel luogo d'origine, dal quale lo tennero lontano gli impegni scolastici e successivamente la docenza universitaria.
Nell'ottobre del 1900 si iscrisse all'Istituto di Studi Superiori di Firenze, grazie ad una borsa di studio; qui, con Gaetano Salvemini, fu discepolo di Pasquale Villari che, con Achille Coen, Gerolamo Vitelli ed Alberto Del Vecchio, influì positivamente sulla sua formazione storiografica e lo avviò ad una sistematica indagine dei problemi meridionali, anche se, in seguito, il Caggese risentì molto il fascino del pessimismo naturalistico di Giustino Fortunato.
Nel 1904 si laureò con il Villari, discutendo la tesi Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII, nella quale, partendo dalla città di Prato, prendeva in esame le problematiche politiche ed economiche della società comunale italiana, già analizzate in due precoci ricerche date alle stampe prima della laurea: Una cronaca economica del secolo XIV e Su l'origine della parte guelfa e le sue relazioni col Comune, destinate, poi, ad essere ancor più approfondite nel saggio Intorno all’origine dei Comuni rurali in Italia.
In seguito la sua ricerca, impostata sui presupposti teorico-storiografici della frattura verticale tra città e campagna e dello sfruttamento intensivo del contado da parte delle nuove classi borghesi urbane, si precisò nell'opera Classi e Comuni rurali nel Medioevo Italiano. Saggio di storia economica e giuridica (voll. 2). Essa, ancora oggi, sebbene superata in alcune sue tesi, resta un punto di partenza insostituibile per ogni indagine che, nel Medioevo italiano, voglia trattare il Comune nel duplice rapporto città-campagna.
Gli studi storici del Caggese, sempre condotti secondo gli indirizzi metodologici della Scuola economico-giuridica malgrado le pungenti critiche di Benedetto Croce, continuarono negli anni successivi sino alla morte. Tappe fondamentali della sua instancabile attività scientifica furono: Gli Statuti della Repubblica Fiorentina (voll. 2); Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia (voll. 3); Roberto d'Angiò e i suoi tempi (voll. 2); L'Alto Medioevo; Dal Concordato di Worms alla fine della prigionia di Avignone.1122-1377.
Nel 1907, il Caggese, dopo avere conseguito a Pavia, il 24 giugno, la libera docenza in Storia Moderna, si trasferì a Napoli, per insegnare in un istituto commerciale: in questo periodo aderì attivamente all'orientamento politico socialista-riformista, avverso con altri settori della Sinistra italiana al sistema di mazzieri e di prefetti imposto da Giolitti.
In qualità di militante del P.S.I. diede il suo apporto alla ricostituzione della sezione partenopea, dirigendone per qualche numero l'organo "Il Socialista", ma nel 1910 si dimise dal Partito per incompatibilità con il filosindacalista Arnaldo Lucci.
Continuò, tuttavia, a pubblicizzare i problemi del Mezzogiorno negli articoli che scrisse sul "Secolo" dal 1912 al 1914 (Il dazio sul grano e l'agricoltura meridionale; La questione meridionale; Il governo e la questione agraria; Per la resurrezione economica dell'Italia…). Se ne fece portavoce, insieme con Giustino Fortunato, Napoleone Colajanni, Ettore Ciccotti, Gaetano Salvemini, presso la società settentrionale della borghesia e della classe operaia. Collaborò a fare conoscere la povertà naturale delle terre, la stretta fiscale che opprimeva i contadini, le sofferenze e le umiliazioni in terra straniera degli emigrati. Denunciò l'incuria del governo verso il Sud. Suggerì ai partiti politici programmi per incanalare verso lo Stato la protesta delle plebi meridionali.
Fu, però, nel 1914 che iniziò il periodo politicamente più importante per il Caggese, il quale, nelle elezioni amministrative del 12 luglio, venne eletto, con l'appoggio del massone socialista Carlo Altobelli, consigliere comunale e provinciale nella coalizione bloccarda di Napoli e negli anni 1916-1917 giunse a svolgere le funzioni di vicesindaco, accanto al Labriola, ed a dirigere di fatto, negli anni del conflitto mondiale, la Deputazione Provinciale.
Nel 1918, si inserì nell’insegnamento universitario come Straordinario di Storia Moderna a Messina e, l'anno successivo, come Ordinario nella stessa disciplina a Pisa.
Di fronte al conflitto mondiale, il Caggese, in consonanza con l'atteggiamento socialista, dapprima si dichiarò neutrale e, successivamente, anche influenzato dall'amico Leonida Bissolati, si schierò a favore dell'intervento, conducendo a riguardo una intensa campagna propagandistica sulle pagine dell'"Idea democratica", organo della Massoneria di Palazzo Giustiniani.
Negli anni del dopoguerra si accentuò in lui quella crisi ideologica, da tempo latente, che lo fece spostare dalle originarie posizioni democratiche a quelle di concentrazione borghese in funzione apertamente antisocialista. Crisi politica sottolineata dalla intensa pubblicistica antigovernativa condotta sulle pagine di giornali come "La Sera"; "Il Mattino"; "Il Telegrafo"; "Il Mezzogiorno" e dal rifiuto della candidatura socialista nelle elezioni politiche in Capitanata del 1919 ed in quelle amministrative di Napoli del 1920.
Prima del delitto Matteotti, il Caggese si avvicinò al Croce ed ai gruppi di Democrazia Liberale e sottoscrisse, nel 1925, il "Manifesto degli Intellettuali Antifascisti". Tuttavia, a distanza di un mese se ne dissociò e si dimise a Napoli dalla amendoliana Unione Nazionale.
Poco dopo aderì al progetto gentiliano dell'Enciclopedia Italiana, alla quale collaborò con un certo numero di voci storiche relative agli Angioini (Carlo I e Carlo II d'Angiò; Giovanna I e Giovanna II; Roberto d'Angiò) ed alla Rivoluzione Francese (Babeuf; Marbois; Berère de Vieuzac; Barras; Bastiglia; Bourmont; Mirabeau…).
Il comportamento politico del Dopo avere occupato, dal dicembre 1923, la cattedra di Storia Economica dell'Istituto di Scienze Economiche di Napoli, ottenne, finalmente, un incarico accademico prestigioso a Milano, dove, dal gennaio 1926 sino alla morte, insegnò, in luogo di Gioacchino Volpe, Storia Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere. Le autorità fasciste, però, poco convinte della sua fedeltà, provvidero ad emarginarlo sempre di più, revocandogli tutti gli incarichi ufficiali e lasciandogli solo l'insegnamento universitario e le lezioni di "Alta Cultura" presso l'Università per Stranieri di Perugia., quindi, non diversamente da quello di tanti altri intellettuali italiani suoi contemporanei, fu molto condizionato dalle forti pressioni esercitate su di loro dall'apparato del Regime, tanto è vero che i 1410 collaboratori dell'Enciclopedia Italiana del 1926 si raddoppiarono nel 1937 e, ancora, quando, nel 1931, il Fascismo impose ai professori universitari il giuramento di fedeltà, solo dodici, contro 1200 si rifiutarono.
Dopo avere occupato, dal dicembre 1923, la cattedra di Storia Economica dell'Istituto di Scienze Economiche di Napoli, ottenne, finalmente, un incarico accademico prestigioso a Milano, dove, dal gennaio 1926 sino alla morte, insegnò, in luogo di Gioacchino Volpe, Storia Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere. Le autorità fasciste, però, poco convinte della sua fedeltà, provvidero ad emarginarlo sempre di più, revocandogli tutti gli incarichi ufficiali e lasciandogli solo l'insegnamento universitario e le lezioni di "Alta Cultura" presso l'Università per Stranieri di Perugia.
A rompere questo isolamento, a nulla servirono le istanze da lui indirizzate ai responsabili culturali del Partito sino a pochi giorni prima della morte, che lo colse, a Milano, il 5 luglio 1938.
La produzione storiografica
La sua ricerca, impostata sui presupposti teorico-storiografici della frattura verticale tra città e campagna e dello sfruttamento intensivo del contado da parte delle nuove classi borghesi urbane, si precisò nell'opera Classi e Comuni rurali nel Medioevo Italiano. Saggio di storia economica e giuridica (voll. 2). Essa, ancora oggi, sebbene superata in alcune sue tesi, resta un punto di partenza insostituibile per ogni indagine che, nel Medioevo italiano, voglia trattare il Comune nel duplice rapporto città-campagna.
Gli studi storici del Caggese, sempre condotti secondo gli indirizzi metodologici della Scuola economico-giuridica malgrado le pungenti critiche di Benedetto Croce, continuarono negli anni successivi sino alla morte. Tappe fondamentali della sua instancabile attività scientifica furono: Gli Statuti della Repubblica Fiorentina (voll. 2); Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia (voll. 3); Roberto d'Angiò e i suoi tempi (voll. 2); L'Alto Medioevo; Dal Concordato di Worms alla fine della prigionia di Avignone.1122-1377.
Nel 1907, il Caggese, dopo avere conseguito a Pavia, il 24 giugno, la libera docenza in Storia Moderna, si trasferì a Napoli, per insegnare in un istituto commerciale: in questo periodo aderì attivamente all'orientamento politico socialista-riformista, avverso con altri settori della Sinistra italiana al sistema di mazzieri e di prefetti imposto da Giolitti.
L'impegno politico nel Partito Socialista
In qualità di militante del P.S.I. diede il suo apporto alla ricostituzione della sezione partenopea, dirigendone per qualche numero l'organo "Il Socialista", ma nel 1910 si dimise dal Partito per incompatibilità con il filosindacalista Arnaldo Lucci.
In qualità di militante del P.S.I. diede il suo apporto alla ricostituzione della sezione partenopea, dirigendone per qualche numero l'organo "Il Socialista", ma nel 1910 si dimise dal Partito per incompatibilità con il filosindacalista Arnaldo Lucci.Continuò, tuttavia, a pubblicizzare i problemi del Mezzogiorno negli articoli che scrisse sul "Secolo" dal 1912 al 1914 (Il dazio sul grano e l'agricoltura meridionale; La questione meridionale; Il governo e la questione agraria; Per la resurrezione economica dell'Italia…). Se ne fece portavoce, insieme con Giustino Fortunato, Napoleone Colajanni, Ettore Ciccotti, Gaetano Salvemini, presso la società settentrionale della borghesia e della classe operaia. Collaborò a fare conoscere la povertà naturale delle terre, la stretta fiscale che opprimeva i contadini, le sofferenze e le umiliazioni in terra straniera degli emigrati. Denunciò l'incuria del governo verso il Sud. Suggerì ai partiti politici programmi per incanalare verso lo Stato la protesta delle plebi meridionali.
Fu, però, nel 1914 che iniziò il periodo politicamente più importante per il Caggese, il quale, nelle elezioni amministrative del 12 luglio, venne eletto, con l'appoggio del massone socialista Carlo Altobelli, consigliere comunale e provinciale nella coalizione bloccarda di Napoli e negli anni 1916-1917 giunse a svolgere le funzioni di vicesindaco, accanto al Labriola, ed a dirigere di fatto, negli anni del conflitto mondiale, la Deputazione Provinciale.
Nel 1918, si inserì nell’insegnamento universitario come Straordinario di Storia Moderna a Messina e, l'anno successivo, come Ordinario nella stessa disciplina a Pisa.
Di fronte al conflitto mondiale, il Caggese, in consonanza con l'atteggiamento socialista, dapprima si dichiarò neutrale e, successivamente, anche influenzato dall'amico Leonida Bissolati, si schierò a favore dell'intervento, conducendo a riguardo una intensa campagna propagandistica sulle pagine dell'"Idea democratica", organo della Massoneria di Palazzo Giustiniani.
La crisi ideologica
Negli anni del dopoguerra si accentuò in lui quella crisi ideologica, da tempo latente, che lo fece spostare dalle originarie posizioni democratiche a quelle di concentrazione borghese in funzione apertamente antisocialista. Crisi politica sottolineata dalla intensa pubblicistica antigovernativa condotta sulle pagine di giornali come "La Sera"; "Il Mattino"; "Il Telegrafo"; "Il Mezzogiorno" e dal rifiuto della candidatura socialista nelle elezioni politiche in Capitanata del 1919 ed in quelle amministrative di Napoli del 1920.
Prima del delitto Matteotti, il Caggese si avvicinò al Croce ed ai gruppi di Democrazia Liberale e sottoscrisse, nel 1925, il "Manifesto degli Intellettuali Antifascisti". Tuttavia, a distanza di un mese se ne dissociò e si dimise a Napoli dalla amendoliana Unione Nazionale.
Poco dopo aderì al progetto gentiliano dell'Enciclopedia Italiana, alla quale collaborò con un certo numero di voci storiche relative agli Angioini (Carlo I e Carlo II d'Angiò; Giovanna I e Giovanna II; Roberto d'Angiò) ed alla Rivoluzione Francese (Babeuf; Marbois; Berère de Vieuzac; Barras; Bastiglia; Bourmont; Mirabeau…).
Il comportamento politico del Caggese, quindi, non diversamente da quello di tanti altri intellettuali italiani suoi contemporanei, fu molto condizionato dalle forti pressioni esercitate su di loro dall'apparato del Regime, tanto è vero che i 1410 collaboratori dell'Enciclopedia Italiana del 1926 si raddoppiarono nel 1937 e, ancora, quando, nel 1931, il Fascismo impose ai professori universitari il giuramento di fedeltà, solo dodici, contro 1200 si rifiutarono.
Dopo avere occupato, dal dicembre 1923, la cattedra di Storia Economica dell'Istituto di Scienze Economiche di Napoli, ottenne, finalmente, un incarico accademico prestigioso a Milano, dove, dal gennaio 1926 sino alla morte, insegnò, in luogo di Gioacchino Volpe, Storia Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere. Le autorità fasciste, però, poco convinte della sua fedeltà, provvidero ad emarginarlo sempre di più, revocandogli tutti gli incarichi ufficiali e lasciandogli solo l'insegnamento universitario e le lezioni di "Alta Cultura" presso l'Università per Stranieri di Perugia.
A rompere questo isolamento, a nulla servirono le istanze da lui indirizzate ai responsabili culturali del Partito sino a pochi giorni prima della morte, che lo colse, a Milano, il 5 luglio 1938.
Scheda
Personaggio
Romolo Caggese
Detto anche
-
Classificazione Dewey
907.202
Periodo MC
Dal 1915 al 1943
Parole chiave
- Comuni rurali
- Democrazia Liberale
- Enciclopedia Italiana
- Fascismo
- Francesco Carabbellese
- Gaetano Salvemini
- Gioacchino Volpe
- Giustino Fortunato
- Massoneria
- Medioevo
- Pasquale Villari
- Prima Guerra Mondiale
- Questione meridionale
- Comune di Firenze
- Comune di Prato
- Rivoluzione Francese
- Roberto d'Angiò
- Scuola Economico-giuridica
- Socialismo
- Unione Nazionale
- Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti de
- Manifesto degli intellettuali italiani antifascisti
Bibliografie
- Opere dell'autore
- Opere sull'autore
- Una cronaca economica del secolo XIV, in "Rivista delle Biblioteche e degli Archivi". Firenze, 7-8, luglio-agosto 1902;
- Su l'origine della parte guelfa e le sue relazioni col Comune, in "Archivio Storico Italiano". Firenze, XXXII, 1903, s. V, 4;
- Il Comune rurale di Tredozio e i conti da Romena. Firenze: Tip. Galileiana, 1904. "Per nozze Schiaparelli-Vitelli";
- Intorno alla origine dei Comuni Rurali in Italia. Roma 1905. Estratto dalla "Rivista Italiana di Sociologia", fasc. II, marzo-aprile 1905;
- La Repubblica di Siena e il suo contado nel secolo decimoterzo, in "Bullettino Senese di Storia Patria", Siena, XIII, 1906
- Note e documenti per la storia del Vescovado di Pistoia nel secolo XII. Pistoia 1907. Estratto dal "Bullettino Storico Pistoiese", fasc. 4;
- Una vecchiezza gloriosa. Pasquale Villari, in "Il Marzocco", Firenze 6 ottobre 1907;
- Classi e Comuni rurali nel medio evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica. Firenze: Tip. Galileiana-Ed. O. Gozzini, 1907-1909 (v. 2);
- Etnografia, Storia e Politica. A proposito del nuovo "Museo di Etnografia Italiana". Rocca S. Casciano 1908. estratto dalla "Rassegna Contemporanea", n. 3;
- L'opera di R. Davidsohn. Documenti e storia di Firenze, in "Il Marzocco", Firenze 5 gennaio 1908:
- La storia di Firenze di R. Davidsohn, in "Il Marzocco", Firenze 1 marzo 1908;
- Nuovi orizzonti della storiografia moderna. Prolusione ad un corso libero di Storia Moderna tenuta nella Regia Università di Napoli il 3 Dicembre 1908. Rocca S. Casciano: Tip. Cappelli, 1909;
- La crisi del partito socialista. (A proposito del Congresso Nazionale), in "La Rivista Popolare". Roma 1910, fasc. I-II;
- Foggia e la Capitanata. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1910;
- Statuti della Repubblica Fiorentina editi a cura del Comune di Firenze da Romolo Caggese. Vol. I: Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325. Vol. II: Statuto del Podestà dell'anno 1325-1921;
- Chiese parrocchiali e Università rurali. Pavia 1911. Estratto da "Studi Storici". XX-2;
- Cinquant'anni di studi storici in Italia, in "Le Cronache Letterarie", S. l., 24 settembre-22 ottobre 1911;
- Gaetano Salvemini storico, in Gaetano Salvemini. Prime elezioni generali a suffragio universale. 26 ottobre 1913. Collegi di Bitonto e di Molfetta. Bari: Cooperativa Tipografica, 1913;
- Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia. Firenze: ed. Succ. B. Seeber e F. Lumachi, 1912.1921 (3 v.);
- Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, in "Rassegna Contemporanea". Roma. N. 11, 10 giugno 1913;
- Gli scritti politici di Antonio Salandra. in "Rivista d'Italia". Roma, fasc. V, 31 maggio 1915;
- Quando è cominciata la crisi del marxismo, in "Il Marzocco". Firenze 3 ottobre 1915;
- Il Mezzogiorno d'Italia e la guerra. Firenze 1916. Estratto dalla "Rivista delle Nazioni Latine", n. 7;
- La scuola professionale e la guerra, in "Italianissima". Rivista mensile inviata a tutti i soci della "Fratelli d'Italia", Milano, 1916, n. 4;
- Il prologo della tragedia europea. Conferenza detta in Roma per la Latina Gens al Teatro della Quattro Fontane il 6 gennaio 1918. Roma: Impr. Gen. d'Affissioni e Pubblicità, 1918;
- Gli studi storici e l'ora presente, in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. XI, 30 novembre 1919;
- Leonida Bissolati, in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. XI, 30 novembre 1919;
- Vita provinciale: sperduti nel buio, in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. I, 15 gennaio 1920;
- Ettore Ciccotti, in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. V, 15 maggio 1920;
- Roberto d'Angiò e i suoi tempi. Firenze: R. Bemporad, 1921-1930. (2 v.);
- Prato nell'età di Dante. Conferenza tenuta da Romolo Caggese nel salone dei Misoduli in Prato il 5 novembre 1921. Prato: La Tipografica, 1922;
- Storia del commercio. Ad uso dei RR. Istituti Commerciali. Firenze: Soc. Anonima Perrella, 1922;
- Mirabeau. Bologna: N. Zanichelli, 1924 (Le Grandi Civiltà. Uomini e Movimenti rappresentativi. Collezione diretta da Guido Manacorda);
- Giovanni Pipino conte d'Altamura, in Studi di Storia Napoletana in onore di Michelangelo Schipa. Napoli: I.T.E.A., 1926;
- Pasquale Villari. Nel primo centenario della nascita (1827-1927), in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. X, 15 ottobre 1927;
- Ciò che è vivo nel pensiero di Machiavelli, in "Rivista d'Italia". Milano, fasc. VI, 15 giugno 1927;
- Storia Moderna. I: Il secolo della dominazione spagnola nella storia della nazione italiana. II: Dal Medioevo alla fine del Rinascimento. Milano: Gruppo Universitario Fascista, 1928-1929. (Lezioni);
- Il Settecento. Il secolo dei pensatori e dei riformatori, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia. Perugia 1929. (Lezioni);
- Storia Moderna. La storia diplomatica d'Europa nel sec. XIX. Milano: Gruppo Universitario fascista, 1929-1930. (Lezioni);
- La Rivoluzione Unitaria Italiana, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia 1930. (Lezioni);
- La civiltà comunale e la originalità della storia della nazione italiana, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia. Perugia 1931. (Lezioni);
- Il trionfo delle signorie cittadine e il rinascimento politico d'Italia, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia. Perugia 1932. (Lezioni);
- Lezioni di Storia Moderna. L'età comunale in Italia. Milano: Tip. Bruni-Marelli, 1931-1932. (Lezioni);
- Italy 1313-1414, in Cambridge Medieval History. Cambridge 1932, v. VII;
- Corso di Storia Moderna. Il Cinquecento. Milano: Gruppo Universitario Fascista "Ugo Pepe", 1932-1933. (Lezioni);
- Il Cinquecento. Luci ed ombre nel Cinquecento politico italiano, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia. Perugia 1933. (Lezioni);
- Ciò che resta della questione meridionale, in "Nuova Antologia", Roma, vol. CCCLXV, 1933;
- Il Seicento. Dominazione straniera e fermenti di indipendenza nell'Italia del Seicento, in Bollettino della Regia Università Italiana per Stranieri. Perugia. Perugia 1934. (Lezioni);
- Storia Moderna. L'ordinamento della Società Italiana nel secolo IX. Milano: Gruppo Universitario Fascista "Ugo Pepe", 1935. (Lezioni);
- La civiltà italiana da Gregorio VII a Bonifacio VIII. Milano: Gruppo Universitario Fascista "Ugo Pepe", 1936. (Lezioni);
- L'epistolario di Letizia Bonaparte, in "Nuova Antologia". Roma, vol. CCCXCI, 1937;
- L'Alto Medioevo. Torino: U.T.E.T., 1937. (GrandeStoria d'Italia);
- Il Trecento e gli albori del Rinascimento. Milano: Gruppo Universitario Fascista "Ugo Pepe", 1936. (Lezioni);
- Dal Concordato di Worms alla fine della prigionia di Avignone (1122-1377). Prefazione di Corrado Barbagallo. Torino: U.T.E.T., 1939. (Grande Storia d'Italia);
- G. ARFE'. Per la storia del socialismo napoletano. Atti della Sezione del P.S.I. dal 1908 al 1911, in "Movimento Operaio", Genova 1953;
- C. BARBAGALLO. Romolo Caggese, in "Nuova Rivista Storica", XXII (1938);
- F. CAPRIGLIONE. La metodologia storiografica di Romolo Caggese. Foggia: Edital, 1981;
- E. CRISTIANI. Città e campagna nell’età comunale in alcune pubblicazioni dell’ultimo decennio, in "Rivista Storica Italiana", Napoli 1962;
- B. CROCE. Professori di storia, in "La Critica", Napoli 1935, v. XXXIII;
- Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1973, v. 16°, ad vocem;
- A. CUTOLO. Romolo Caggese, in "Archivio Storico Lombardo", LXV (1938);
- M. FATICA. Origini del Fascismo e del Comunismo a Napoli (1911-1915). Firenze: La Nuova Italia, 1971;
- M. SIMONETTI. Storiografia e politica avanti la grande guerra. Romolo Caggese fra revisionismo e meridionalismo (1911-1914), in "Archivio Storico Italiano". Firenze 1973;
- G. TURI. Il progetto dell’Enciclopedia italiana: l'organizzazione del consenso fra gli intellettuali, in "Studi Storici", Roma 1972, n. 1;
- A. VENTURA. Romolo Caggese tra storiografia e politica (1881-1981), in "Rassegna di Studi Dauni", VII-VIII, Foggia 1980-1981;
- G. VOLPE, Romolo Caggese, in "Rivista Storica Italiana", s. 5, III (1938).
Per approfondimenti bio-bibliografici, consulta il FONDO ROMOLO CAGGESE all'interno di Collezioni Speciali di Biblioteche Private del La Magna Capitana
A cura di Antonio Ventura
